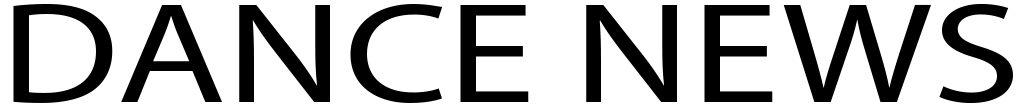Preceduto dal ricco “Omaggio a Jerome Robbins al Teatro Costanzi”, per la stagione 2019/2020 del Teatro dell’Opera di Roma, un secondo ossequio ad uno dei maggiori coreografi del ‘900, è in scena, dall’8 al 17 maggio, al Teatro Lirico di Cagliari: “West Side Story”.
Il musical in due atti nell’allestimento della Lyric Opera of Chicago, della Houston Grand Opera e del Glimmerglass Festival. Maestro concertatore e direttore è Donato Renzetti, con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, e la regia di Francesca Zambello.
È difficile immaginarlo oggi, dopo che “West Side Story” è diventato un punto di riferimento per ogni musical che si rispetti, non si contano più le edizioni discografiche, si accumulano riallestimenti in ogni angolo del mondo e la versione cinematografica (1961) è riproposta con successo ovunque, come esempio ed oggetto di studi, con l’ammirazione di sempre. Tanto che, all’indomani della tragedia dell’11 settembre 2001, il film, con la regia di Robert Wise e di Jerome Robbins (in seguito estromesso dalla produzione per il suo far lievitare i costi all’infinito), è stato proiettato nel back front di un edificio a New York. È stato questo il modo, preciso, di slancio, per dire al mondo che la città, pur piagata, umiliata, era più viva che mai, e ritrovava se stessa, le sue radici, in quelle immagini.
Eppure, prima di andare in scena, in prima assoluta, il 19 agosto 1957, al National Theatre, Washington, l’allestimento venne considerato una stranezza artistica, un possibile “veleno” per il botteghino. Tanto che i produttori di Broadway convocati, i pochi disposti a farlo, si dileguarono, uno dopo l’altro. La partitura di Leonard Bernstein (1918-1990), era considerata difficile, non adatta per un musical; i testi delle canzoni di Stephen Sondheim (1930) inutilmente descrittivi, troppo minuziosi; il libretto di Arthur Laurents (1917-2011) incomprensibile. Per il debutto a Washington, è ancora eloquente la testimonianza di Carol Lawrence, interprete di Maria nella produzione originale. “Alla chiusura del sipario”, ricorda l’artista, “seguì un silenzio di tomba per qualche secondo. Tutti noi pensammo che lo spettacolo fosse morto alla nascita. Improvvisamente, il pubblico balzò in piedi, urlando e piangendo, in una danza colma di rabbia e amore, ansia e liberazione, appagamento concreto e bisogno di trascendenza”.
Dopo la prima tappa del rodaggio, il musical aprì a Broadway, Winter Garden Theatre, il 26 settembre 1957; qui rimase in scena per 732 repliche. Chi aveva presentito e investito tutto nel risultato, e ci credeva più di ogni altro, era colui che, per primo, ne aveva elaborato, idealmente, il nucleo: Robbins, il coreografo. Per lui il lavoro, che usava l’immagine della guerra fra bande per interrogare il sogno americano e l’esperienza dell’immigrazione, sarebbe dovuto nascere alla fine degli anni ’40: pensava ad una versione contemporanea di “Romeo e Giulietta”, da Shakespeare, in una perfetta combinazione di danza, musica e teatro, e in omaggio al suo partner, Montgomery Clift. Ma l’ascesa siderale dell’attore come star di Hollywood, tagliò le ali al progetto e al rapporto, in anni in cui l’omosessualità era punita per legge, e costituiva una minaccia intollerabile per un divo del cinema. La bozza iniziale non venne però abbandonata. Negli anni si indirizzò ad uno scontro fra ebrei e cattolici, infine a vincere fu l’idea della violenza fra bande, che permetteva ai quattro autori, figli di ebrei immigrati, di oggettivare e spostare il proprio senso di estraneità su altre animosità tribali, esperienza di per sé liberatoria.

Per istinto, e sapienza, Robbins, che ben conosceva i modi della cultura popolare e gli anfratti della psicologia umana, dispiegò con furore e forza tali consapevolezze nel musical. Ancora oggi il prologo si mostra vigoroso e rivoluzionario: i Jets, bianchi, e gli Sharks, portoricani, le due bande di New York che cercano di distruggersi a vicenda, sono introdotti dal movimento. Scatti e schiocchi delle dita si inseguono, e volano corse, salti, calci, cariche, fughe e rincorse, gli uni che superano gli altri in deflagrazioni danzate. È in queste sequenze che Robbins offre il meglio di sé: nella trasformazione stilizzata dei movimenti più banali e ordinari, nel sublimare i gesti quotidiani, nel mostrare come le due compagini maschili (soprattutto loro, ma non solo loro), “scivolino”, danzando, dalla camminata al confronto, dal flirt all’interno del gruppo all’aggressione degli “altri”, dalla scazzottata alla pacificazione al duello, mentre attraversano il proprio territorio per esaltarlo e difenderlo.
È un giro vorticoso che mentre dischiude e dipinge l’aggressività virile, illustra l’architettura di quella parte di New York, l’Upper West Side: vicoli, cortili, marciapiedi, sottopassi, impalcature, edifici vuoti e devastati. I danzatori abitano, riempiono e disegnano il tutto in pose spogliate d’ogni artificialità, congruenti al luogo e al racconto come altrettanti graffiti antropici. L’affresco di varia umanità che ne deriva è brusco, sporco, politicamente pesante; è “alleggerito” dal dinamismo spinto delle danze, ma parla con eloquenza di sé, dei rischi della metropoli e di quanto rimane aperto delle mille questioni della vita contemporanea. È tutto lì, fra povertà, immigrazione, razzismo, discriminazioni di genere, prevaricazione del maschile sul femminile, e le alterazioni patologiche dell’essere e del vivere in condizioni abbrutite da violenza sessuale, conflitti, ferocia della polizia, con il fato già scritto nel dramma sin dalla prima scena.
West Side Story è, fondamentalmente, uno show tanto vitale quanto crudele, tagliato con il coltello: parla di un mondo senza adulti e genitori, di giovani sostanzialmente orfani, costretti a vivere o a soccombere nella giungla metropolitana secondo le proprie capacità o debolezze; e definire i confini del proprio territorio è la conferma primaria del loro diritto all’esistenza. In questo angolo di mondo, il balletto, e dopo di lui il film, si muovono con la velocità degli istinti adolescenziali. I personaggi, imbevuti dell’animus generato dal gruppo, da un codice genetico che li governa e di volta in volta li controlla o li sovreccita, non hanno tempo di pensare a ciò che fanno, e vivono nel momento: si battono, danzano, uccidono, soffrono, danzano ancora, uccidono di nuovo. La drammaturgia, la tempistica e gli effetti che ne derivano, vanno dritti al cuore: narrano la storia e descrivono la vita esattamente come è, con la sola intermediazione, il solo “filtro” conduttore forniti dalla musica e dalla danza.

La leggenda, una delle tante fiorite intorno al musical, vuole che Robbins abbia preso in prestito e filtrato il basculamento dei fianchi, l’esplosione delle braccia, l’affondo delle gambe, dalle danze di giovani allievi di una scuola nel quartiere latino di Harlem, fra caroselli di mambo, swing e lindy hop. Derivata da “furti” o meno, è un’energia frenetica quella che innerva i movimenti dell’intero lavoro, a metà strada tra ballare, combattere e il gridare al mondo la propria identità. L’esito finale è comunque il frutto della preziosa sinergia di quattro talenti: artisti giovani, ambiziosi e irrequieti, che riconoscevano, l’uno nell’altro, punti di forza e capacità complementari, protese verso una sintesi di linguaggio drammatico. Lo componevano la scrittura sobria, contenuta nei sentimenti, di Laurents; il calore emotivo e la competenza di Bernstein, la sua capacità di sintetizzare e unire, in musica, più universi; il talento di Sondheim per saldare il divenire della trama nei testi delle canzoni, condite di sapida modernità; lo spietato perfezionismo di Robbins, instancabile nel cercare e pretendere il meglio, da tutti, con l’istinto del vulcanico uomo di spettacolo.
L’operato di Robbins, in particolare, emergeva vistosamente. Il senso di riconoscibile realismo da lui apportato alle danze e ai movimenti nasceva da una sua feroce “visione monocratica”: scelto ciò che voleva, più nulla contava, a costo di abbaiare a collaboratori e danzatori, quest’ultimi costretti a ripetere passi e battute sino alle lacrime e allo sfinimento, tra urla e insulti. Ma oltre che dalla cultura ebraica d’origine, tutti e quattro gli autori erano accomunati da gradi diversi di accettazione e rifiuto della propria omosessualità; così che una storia d’amore proibita divenne un ragionevole modo per raccontare, occultata sottotraccia, la propria vita.
Ermanno Romanelli